F.Petronella-ISPI
Uno scenario inimmaginabile fino a poche ore fa, ma diventato estremamente concreto in pochissimo tempo. Questo, in estrema sintesi, rappresenta per Israele l’escalation iniziata all’alba di sabato, 7 ottobre, quando un’offensiva via terra, aria e mare è partita dalla Striscia di Gaza contro lo Stato ebraico. L’iniziativa di Hamas, movimento palestinese di matrice islamica, ha poco a che vedere – per effetto e portata – con le precedenti escalation tra lo Stato ebraico e l’enclave costiera. Rischia quindi di innescare instabilità diffuse non solo a livello locale, ma anche regionale e internazionale. Quello che alcuni osservatori chiamano già “l’11 settembre di Israele” si inserisce come un cuneo nel percorso di normalizzazione tra Israele e i paesi arabi della regione, iniziato con gli Accordi di Abramo nel 2020. Sarebbe un errore, tuttavia, legare l’accaduto a ragioni meramente geopolitiche e legate al contesto internazionale. Le radici della crisi, probabilmente la più grave di sempre per Israele, sono da rintracciare nelle dinamiche locali, di un conflitto incancrenito e, allo stesso tempo, sempre più negletto dalle agende politiche internazionali.Cosa cambia questa voltaNegli anni scorsi, ad esempio ad agosto del 2022 o a maggio del 2023, si sono verificate varie crisi violente, ma temporalmente circoscritte e caratterizzate da passaggi ricorrenti: evento scatenante (come scontri sulla spianata delle moschee a Gerusalemme), lancio di razzi da Gaza (quasi sempre respinti dal sistema di protezione Iron Dome), raid israeliani nell’enclave, cessate il fuoco raggiunto – molto spesso – con la mediazione dell’Egitto. L’ultima escalation, invece, ha una dimensione completamente diversa. Per la prima volta, infatti, i gruppi armati che controllano Gaza dal 2006 hanno avviato anche una vera e propria incursione di terra, anche utilizzando deltaplani per atterrare in territorio israeliano, attraverso i tunnel – che le forze israeliane si affannano costantemente a rintracciare e distruggere – e perfino prendendo il controllo con la forza del valico di Beit Hanoun/Erez, cruciale e sorvegliatissima via di accesso alla Striscia. Le immagini dei miliziani palestinesi che sciamano “liberamente” per le strade di Israele sono una dimostrazione di fragilità senza precedenti per lo Stato ebraico. Tanto che Hamas e il movimento del Jihad Islamico (Pij) hanno insistito molto su questo punto anche a livello propagandistico. Le incursioni nel sud di Israele, hanno evidenziato le organizzazioni combattenti, sono state precedute da un “disturbo di massa dei sistemi di comunicazione e sorveglianza”, che ha consentito ai combattenti di entrare nel Paese praticamente inosservati.
Al momento non è possibile formulare giudizi solidi, ma come evidenziato da diversi osservatori potrebbe trattarsi di un gravissimo “buco” dell’intelligence israeliana, in particolare del Mossad e dello Shin Bet, avvenuto in una delle zone più sorvegliate al mondo. Cercando di comprendere le tempistiche dell’iniziativa palestinese, per rispondere alla pressante domanda “Perché ora?”, vale forse la pena inserire nell’equazione anche la complessa situazione interna dello Stato ebraico. Il paese, infatti, è ancora in fermento per la controversa riforma della giustizia voluta dal premier Benjamin Netanyahu, che cerca di ridimensionare i poteri della Corte Suprema in favore dell’esecutivo e della Knesset, il parlamento monocamerale israeliano.Il progetto di riforma è stato osteggiato negli scorsi mesi non solo dalla società civile, ma anche da ampi settori degli apparati di sicurezza. Nel tentativo di tenere in piedi il governo, Netanyahu ha concesso spazio e potere alle anime più estremiste dell’esecutivo, come il ministro della Sicurezza interna Itamar Ben Gvir. Non è del tutto da escludere l’idea che Hamas abbia colto l’occasione, sfruttando un attimo di particolare debolezza e divisione all’interno dello Stato ebraico per assestare un colpo micidiale alla sua sicurezza e alla percezione della sua sicurezza. Non a caso, poco dopo l’inizio dell’offensiva, il movimento islamico ha invitato gli arabi di Israele a unirsi alla lotta e a sollevarsi contro lo Stato ebraico. Questo risponde in parte alle domande sull’entità dell’attacco, troppo meticoloso e articolato per essere stato estemporaneo. A Gaza, infatti, potrebbero aver maturato l’idea e organizzato l’offensiva per mesi, magari avvalendosi di aiuti esterni, per poi agire approfittando delle divisioni interne di Israele.Valore simbolico e scenario regionaleNel tentare di spiegare le tempistiche dell’escalation è difficile non notare la concomitanza, 50 anni e un giorno, con l’anniversario della Guerra dello Yom Kippur (1973). Con quell’evento storico, peraltro, la crisi attuale condivide un altro aspetto: l’obiettivo di sparigliare lo status quo, o almeno mostrare di poterlo fare. Questo elemento aggiunge certamente un valore simbolico non trascurabile, come pure il nome scelto da Hamas e Pij per l’operazione: “Tempesta di Al-Aqsa”. Gerusalemme e le sue moschee, infatti, ricorrono spesso nell’iconografia palestinese, ma il riferimento ad Al-Aqsa contiene anche un messaggio diverso, che riguarda il contesto regionale. Il destinatario, difatti, potrebbe essere l’Arabia Saudita, paese che ospita gli altri due luoghi sacri dell’islam (Mecca e Medina), mentre Gerusalemme è la terza città santa per i musulmani di tutto il mondo.
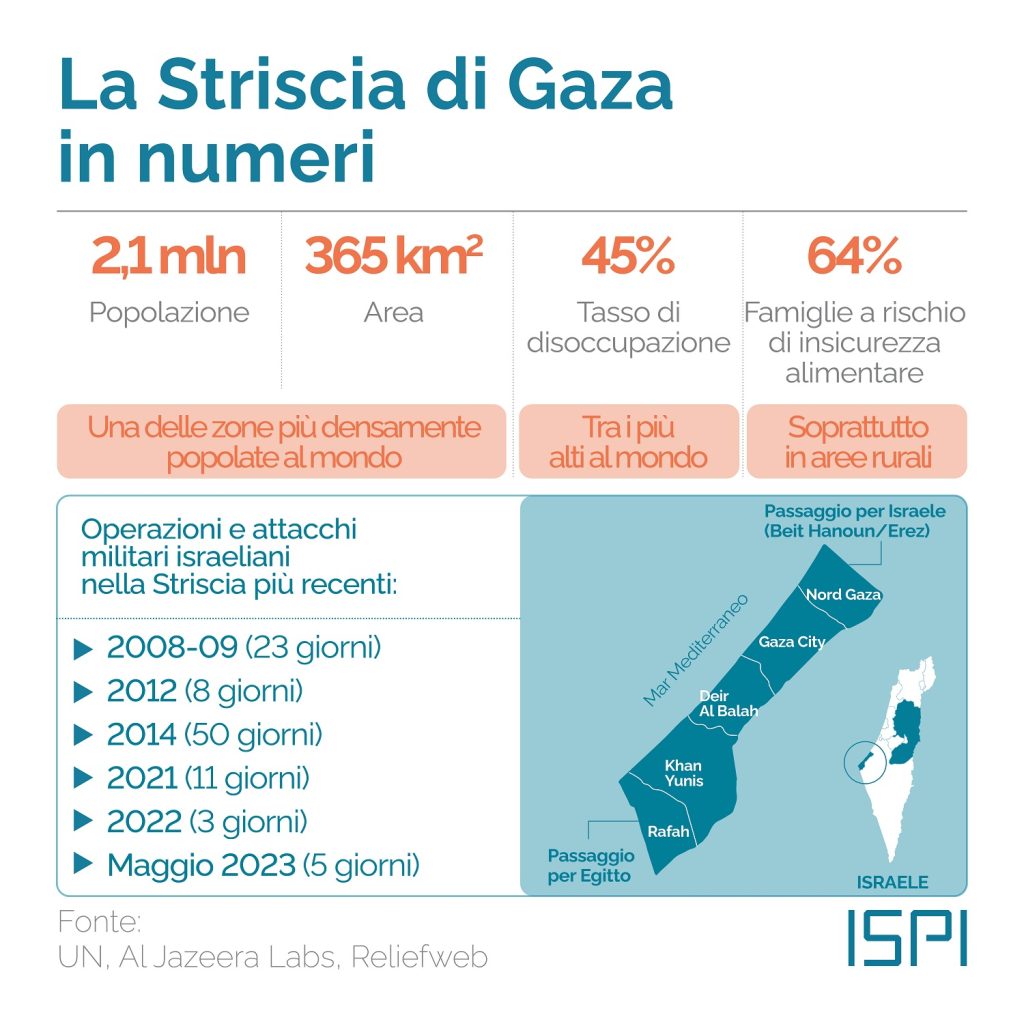
Proprio in queste settimane, il regno arabo saudita è impegnato in fitti negoziati con gli USA, che dovrebbero portare alla definitiva normalizzazione delle relazioni tra Riad e Israele. Sarebbe il coronamento del percorso degli “Accordi di Abramo”, patrocinati a partire dal 2020 dall’amministrazione americana di Donald Trump, e che finora hanno coinvolto Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Sudan e Marocco. L’escalation rischia di segnare una battuta d’arresto per questo processo. I sauditi – così come gli emiratini – sono stati tra i primi a chiedere una cessazione delle ostilità, puntando il dito contro l’occupazione israeliana ma senza mostrare sostegno verso l’offensiva palestinese.Il Qatar, invece, ha rilasciato una dichiarazione chiedendo moderazione a entrambe le parti, ma precisando di ritenere responsabile Israele. A guadagnarci a livello di immagine è probabilmente l’Iran, la cui guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato: “Oggi la gioventù palestinese e il movimento palestinese sono più energici, più vivi e più preparati di quanto lo siano mai stati negli ultimi 80 anni”. Il partito-milizia libanese Hezbollah, sciita e legato a Teheran, ha rivendicato nella mattina di domenica il lancio di razzi e colpi di mortaio dal sud del Libano contro tre posizioni dell’IDF nel Nord di Israele, nei pressi del monte Dov. Non stupirebbe se il coinvolgimento del “Partito di Dio” si facesse via via più deciso nei prossimi giorni.
Sarebbe un errore, tuttavia, ricercare le radici di quanto sta accadendo solo nel contesto politico e diplomatico regionale. Iniziative come gli Accordi di Abramo si basano proprio sull’idea che per risolvere il conflitto sia sufficiente “scavalcare” di fatto i palestinesi, interagendo e facendo accordi direttamente e solo con i vicini arabi. Questa postura, unita alla pretesa di quasi tutti i governi israeliani di poter vivere in uno stato di militarizzazione perenne (per quanto a bassa intensità), contribuisce al rafforzamento dei movimenti politici più intransigenti come Hamas e Pij.
Vale la pena valutare, infine, anche la componente generazionale. Il 2023 non ha segnato solo i 50 anni dalla guerra dello Yom Kippur, ma anche i 30 anni dagli accordi di Oslo. L’intesa, siglata a settembre del 1993, si basava sulla soluzione a due Stati che ancora oggi rappresenta la posizione ufficiale praticamente dell’intera comunità internazionale. La crisi di oggi potrebbe rappresentare un colpo mortale e definitivo per quello che resta di quegli accordi, considerato che la risposta di Israele non potrà che essere durissima, come chiarito da Netanyahu nella serata di sabato. Inoltre, molti dei miliziani palestinesi di oggi – che nei video diffusi in rete brandiscono kalashnikov e catturano mezzi militari israeliani – hanno fra i 20 e i 35 anni. Fanno tutti parte della “generazione Oslo”: sono nati, cioè, poco prima o addirittura dopo la firma dei protocolli e – non avendone mai visto una vera implementazione – non credono minimamente alla soluzione a due stati. Rifiutano poi l’idea, centrale nel ventennio di Netanyahu, che lo status quo sia in qualche modo “sostenibile”, e che la soluzione politica sia di fatto rinviabile sine die. Erano dei bambini quando – nel 2007 – Hamas e Fatah instauravano il duopolio, Gaza e Cisgiordania, che ancora oggi domina i territori palestinesi, in cui non si vota da allora. Di fronte a una comunità internazionale sempre più disinteressata a quella che per mezzo secolo è stata “la questione” per eccellenza, molti di loro trovano nella lotta armata l’unica via.

